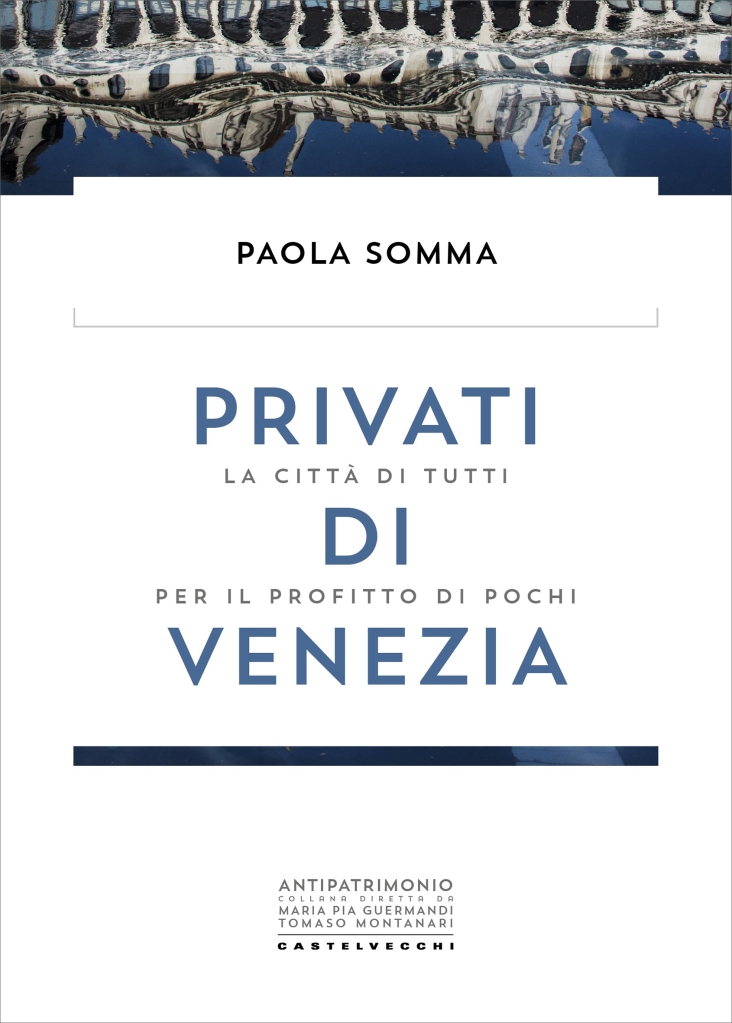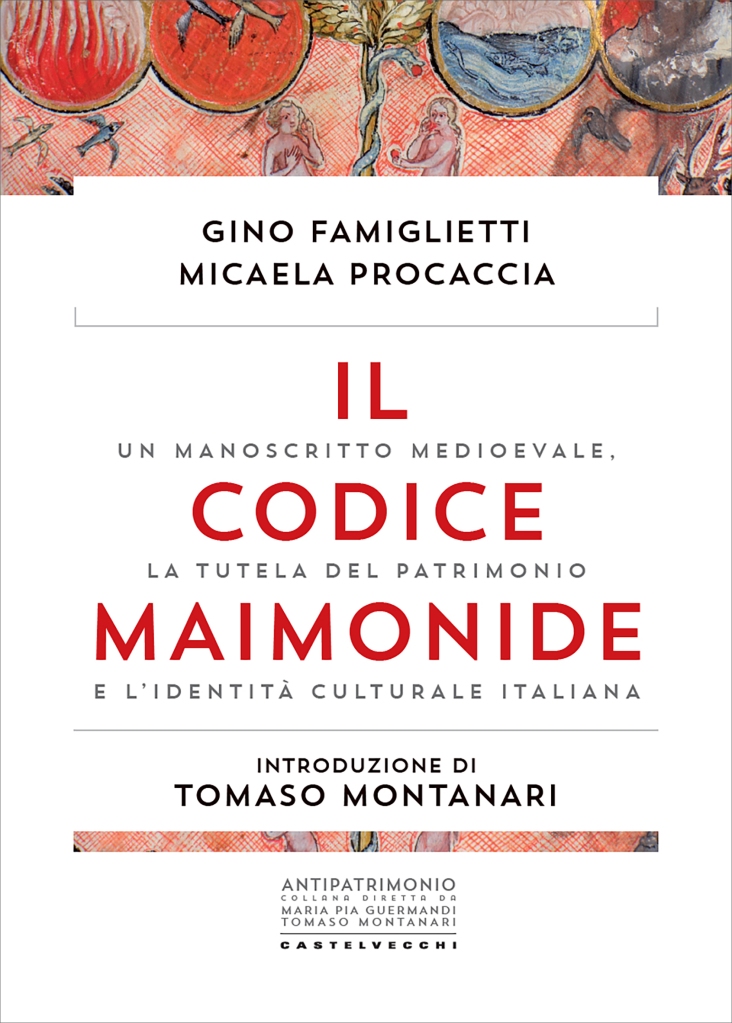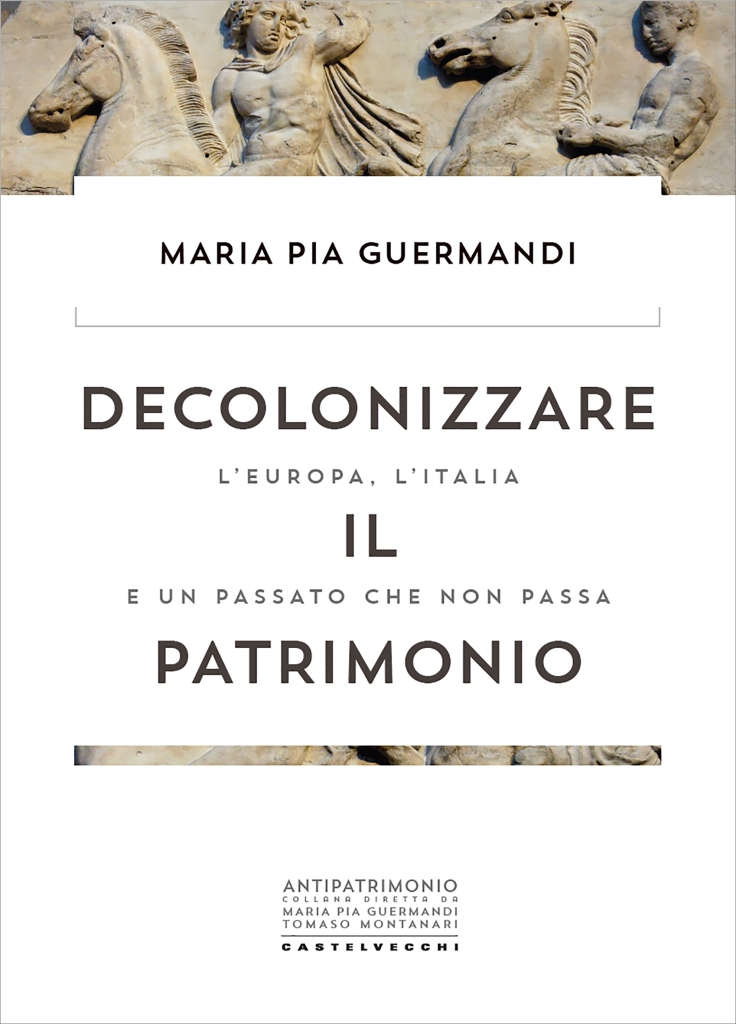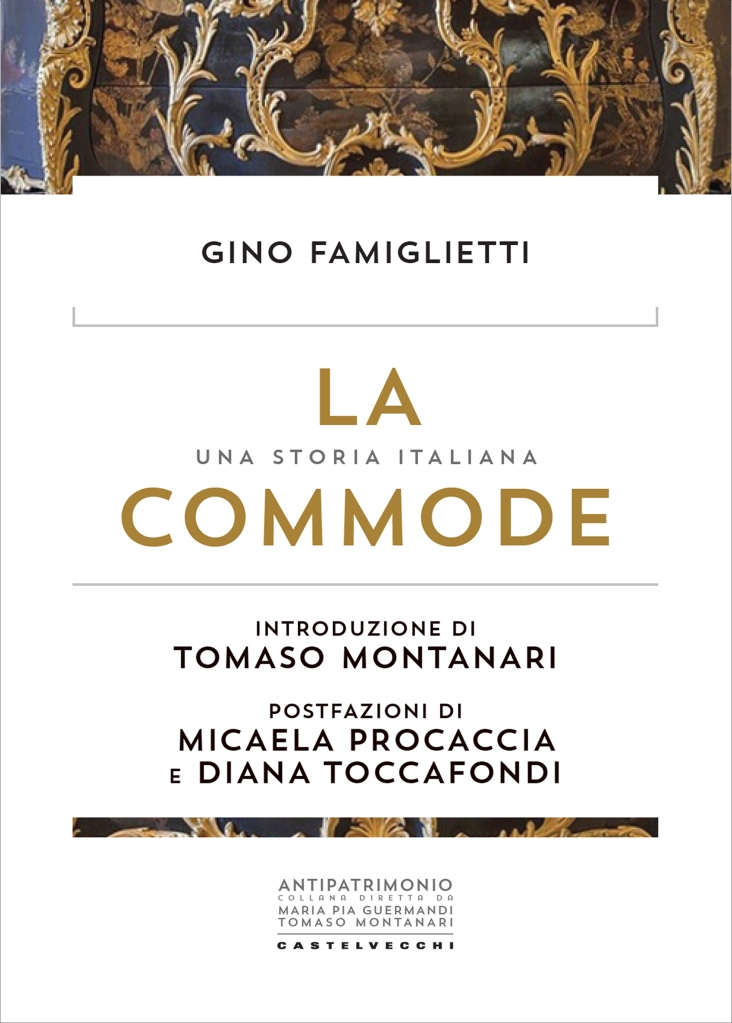Tomaso Montanari
“Mi piacerebbe sapere chi è il mandante di tutte le cazzate che faccio”. Questa immortale sentenza di Altan dovrebbe essere scolpita a caratteri cubitali sull’ingresso del ministero dell’Istruzione, almeno stando alle dichiarazioni del suo ineffabile titolare attuale, Patrizio Bianchi. Parlando dell’incredibile concorso per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, questi ha candidamente ammesso che “è un concorso che abbiamo ereditato dal passato, con una modalità di organizzazione anche delle prove che si è dimostrata non adeguata”. E allora, chi è il mandante? Un appello, che sta ricevendo moltissime adesioni nel mondo intellettuale italiano, rileva che “la qualità dei quesiti va ben al di là della peggiore delle ipotesi. Ai partecipanti, quando è andata bene, sono state sottoposte domande più mortificanti dei quesiti di un telequiz televisivo. Innumerevoli gli esempi di quiz mal posti, fuori programma, erronei, anche ambigui, formulati con l’obiettivo di decimare in qualche modo la platea dei concorrenti più che di selezionare i migliori”.
La conclusione dei firmatari è l’unica possibile: “Il ministero dell’Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine e decine di quesiti inaffidabili e provvedere a ridefinire i punteggi dei candidati interessati. Migliaia di partecipanti al concorso sono vittime di batterie di test a scelta multipla che, per la pessima qualità dei quiz proposti, sono un’offesa all’oggettività e al merito, oltreché alle vere competenze (e connoscenze) da accertare in una pubblica selezione per l’accesso ai ruoli della scuola”.
In particolare, le domande per le cattedre di Arte e immagine e di Storia dell’arte sono davvero lunari, spesso discutibili, a volte clamorosamente errate (Donato Bramante, per dire, che diventa “Andrea Bramante”…). Sembra che al ministero si sia ancora fermi all’immagine felliniana dell’insegnamento della storia dell’arte. Nell’esilarante galleria di professori reinventata da Fellini in Amarcord, alla storia dell’arte tocca inevitabilmente un’anziana signorina, che, mentre inzuppa leziosamente un biscottino nel caffé, cantilena, tra lazzi e puzze dei suoi irrispettosi studenti: “Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante, nella storia dell’arte? Ve lo dico io, il perché: perché Giotto ha inventato la prospettiva. La pro-spe-tti-va…”.
Nei test di oggi ci si vorrebbe sentir dire che “nella Pietà di San Pietro, opera giovanile di Michelangelo, ritroviamo una composizione a spirale che culmina nel volto della Madonna”. Questa, che per il Ministero sarebbe la risposta giusta, è invece insensata, arbitraria e discutibile non meno delle alternative (una sola delle quali è manifestamente errata).
Poi il candidato avrebbe dovuto capire che “diciamo ancora di influenza verrocchiesca l’Annunciazione di Leonardo” perché apparirebbe “fin troppo decorativa negli ornamenti, nei panneggi elaborati e nella minuziosa resa dei fiori”. E qui sia Verrocchio che Leonardo, se potessero, inseguirebbero con un forcone la commissione che ha scritto simili scempiaggini. Nella Lombardia del Settecento, poi, si affermerebbe “il genere pittorico del realismo”: non lo ma il genere! Una cosa per cui un candidato medio avrebbe dovuto sentirsi offeso, bocciando in cuor suo commissione e Ministero.
Il tutto immerso in un delirio mnemonico in cui diventa vitale ricordarsi se un certo quadro del Cinquecento è su tela o su tavola, o in cui si mettono sullo stesso piano attribuzioni inventate e vecchie proposte attributive tuttora discusse (è il caso della domanda sul Bernini restauratore dell’antico “con il suo peculiare stile”, qualunque cosa voglia dire). Affiora, a tratti, una visione militare e meccanicamente pugnace della storia dello stile, per cui Artemisia Gentileschi “opponeva al classicismo di scuola carraccesca il suo vigoroso caravaggismo”: in sintesi, una boiata pazzesca.
In generale, l’immagine dello storico dell’arte che promana da questo cumulo di macerie intellettuali sembra la caricatura di una caricatura: quella del critico d’arte Armà, immortale creatura di Corrado Guzzanti. La retorica, l’ecfrasis sovraccarica, l’entusiastica fiducia nelle etichette più improbabili (l’immortale “nascondismo”…): ecco il mondo mentale in cui sembrano esser nate queste stralunanti domande su cui si dovrebbe giocare il futuro delle vite degli aspiranti professori, e quello delle teste dei loro malcapitati allievi.
Al contrario, l’obiettivo finale dell’insegnamento scolastico della storia dell’arte dovrebbe essere mettere in grado i cittadini italiani di camminare per un quarto d’ora nella loro città sapendo leggere la straordinaria stratificazione dello spazio pubblico che li accoglie. Annullare questo penoso concorso e rifarne uno orientato a quello scopo sarebbe una bella prova di serietà e consapevolezza di sé. Ma da questo ministero “all’Altan” ce lo possiamo mai aspettare?
Articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” il 4 luglio 2022. Immagine di copertina: Norman Rockwell, Art Critic (particolare), 1955 (Norman Rockwell Museum).
Leggi anche
Altri articoli
Il Paesaggio, la Costituzione , gli attacchi alle Soprintendenze e le solidarietà pelose
Claudio Meloni - FP CGIL