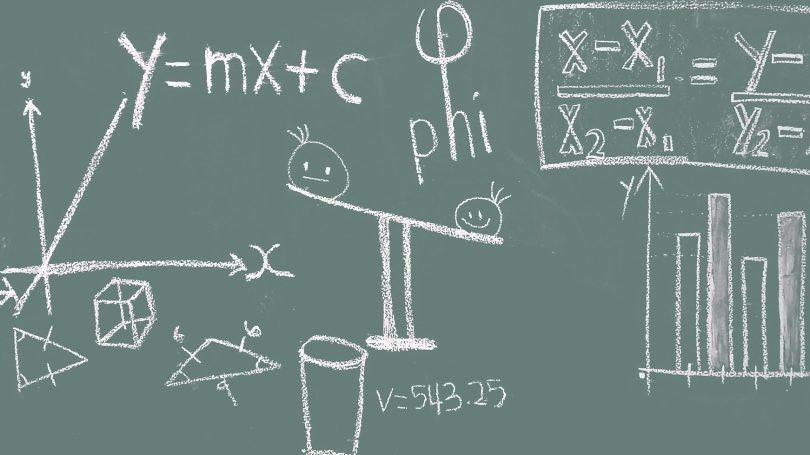Tomaso Montanari
Come ogni anno nei giorni in cui inizia la primavera, Libera ci invita alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ebbene, Antonino Capponetto non si stancava di ripetere che “la mafia teme la scuola più della giustizia”.
Ma se vogliamo che queste parole ci scuotano fin nelle viscere, allora dobbiamo chiederci: di quale scuola ha davvero paura la mafia? Di quale università? Di quale cultura?
Danilo Dolci, mite profeta di giustizia, lo spiegava nel 1955. Per vincere la mafia, scriveva, “occorre una scuola che collabori alla realizzazione del mondo nuovo. Efferati o incoscienti si è, se non si dà modo subito a tutti di partecipare alla vita: di lavorare, studiare, curarsi, di partecipare alla pari alla responsabilità, alla vita pubblica. Cominciando a garantire proprio gli ultimi, quelli che non ce la fanno, a qualsiasi costo (costo giusto, si capisce): proprio, in un certo senso, il contrario di come si sta facendo”.
Il contrario di come si sta facendo: le parole, miti ma chiarissime, di Dolci colpiscono anche le nostre sicurezze di oggi. Ci invitano a convertirci: cioè, letteralmente, a cambiare strada. Perché la scuola che fa paura alla mafia è quella della Costituzione: quella che forma cittadini. Per esempio, rifiutandosi di formare pezzi di ricambio per lo stato delle cose (per esempio con l’alternanza scuola-lavoro intesa come una palestra di schiavitù), ma trasmettendo, accanto agli strumenti cognitivi e a quelli culturali, il pensiero critico necessario per essere cittadini. E dunque per esercitare un discernimento civico, anche in relazione al voto: “La buona scuola reale è quella che interroga il mondo per cambiarlo, non quella che insegna ad adattarsi al mondo com’è” (Andrea Ranieri). Invece, la scuola che traveste l’ingiustizia sociale da “meritocrazia” non fa affatto paura alla mafia: perché non è la scuola che prepara il mondo nuovo, ma una scuola che cementa il mondo vecchio. Una scuola che di fatto seleziona per censo, lasciando intatti i privilegi, non forma alla giustizia, ma alla legge del più forte: che è proprio quella in cui la mafia si riconosce. “Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo d’espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose”: sono parole di don Lorenzo Milani.
Ed è purtroppo ancor più verso la diseguaglianza che la Dad della pandemia ha spinto la scuola italiana.
All’università le cose vanno ancora peggio, se possibile. Oggi si laurea solo il 5,3% dei figli di genitori senza titolo di studio, il 14% dei figli di genitori con la sola licenza elementare, il 45% dei figli di diplomati e l’83,6% dei figli di laureati. E le università non condividono il sapere con i cittadini ma propongono una offerta formativa a clienti. E vengono misurate attraverso ottusi meccanismi aziendalistici, che alcuni vorrebbero spingere fino a creare un’oligarchia della ricerca.
Ma, allora, che posto ha la giustizia nell’università italiana di oggi? E, per dirla proprio tutta, che paura può fare alla mafia un’università sempre più devastata da fenomeni di corruzione, di potere, di concorsi truccati? Fenomeni per i quali le procure ravvisano il reato di associazione a delinquere, e i giornali parlano, non a torto, di “mentalità mafiosa”: perché fondata sull’appartenenza a clan accademici, perché violentemente vendicativa, fortemente gerarchica e acritica. Davvero pensiamo che questa università possa fare paura alla mafia?
Qualche anno fa, l’allora presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche disse letteralmente che “il dovere nostro è di fare andare avanti l’Italia . Quindi, di fare sinergie, mettere insieme le forze, senza pensare a principi etici”. Se vogliamo che le parole – profetiche – di Antonino Caponnetto siano ancora vere, dobbiamo costruire una scuola e un’università che invece pensino, eccome, ai principi etici. Quelli della nostra Costituzione: l’eguaglianza sostanziale da costruire, il pieno sviluppo della persona umana come obiettivo, il rifiuto del principio d’autorità e il primato del pensiero critico. Ci vuole un’università in cui un giovane brillante nato in una famiglia povera, emarginato dalla scuola pubblica e quindi “adottato” da un clan mafioso e avviato a una formazione da manager, da colletto bianco al servizio degli interessi criminali – sappiamo bene quante storie così esistono davvero – ebbene, un’università in cui quello studente brillante e destinato al peggio possa imparare che il successo e il profitto non sono l’unico metro; possa imparare non solo una tecnica che lo renda competente ed esperto, ma anche un orientamento morale, e una responsabilità civile; possa incontrare professori spogli di ogni potere, se non quello della conoscenza: non padroni, capi, baroni, ma servitori del bene comune. E che, allora, almeno un dubbio possa attraversargli la mente: facendogli vedere che c’è un’alternativa.
Che un riscatto è possibile.