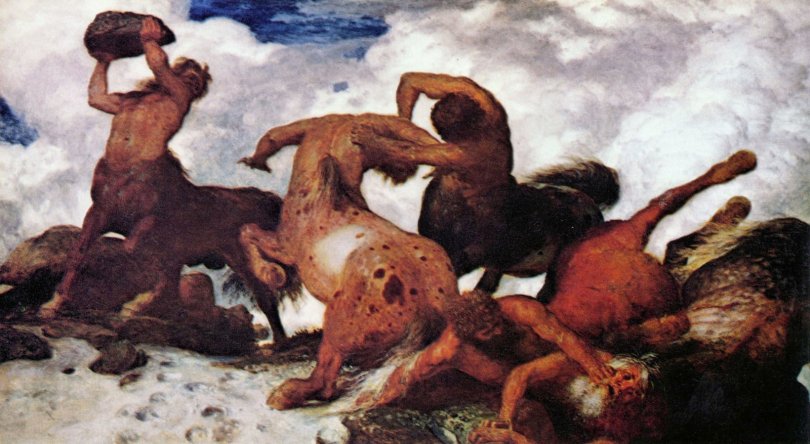La riforma dei musei statali - venti dei quali resi autonomi con un proprio dirigente, gli altri staccati dalle soprintendenze e aggregati ai poli museali regionali appena inventati - ha finora dato la stura a molte banalità mediatiche, oscillanti fra la celebrazione incondizionata del sol dell’avvenire e la stroncatura senza attenuanti dell’intera operazione.
In entrambi i casi insistendo sul fatto che i nuovi direttori, selezionati da un concorso internazionale, sono tutti esterni all’amministrazione (tranne uno) e in buona misura stranieri. L’efficacia del processo andrà valutata almeno nel medio periodo, quando sarà a regime. Ma intanto merita riflettere sul suo senso considerando due aspetti centrali di cui si è finora parlato incredibilmente poco, oltre i lanci di campagna stampa.
Il primo è che la cosiddetta riforma dei musei è in verità una riforma degli uffici di tutela e insieme della tutela stessa del patrimonio culturale, che di fatto tende a scomparire dall’agenda ministeriale. Dividendo le proprie forze in uffici territoriali svincolati dai musei, ovvero accorpati in modo che le antiche e gloriose soprintendenze ai beni artistici siano fagocitate da uffici misti a trazione architettonica, lo stato abdica a quella che dovrebbe essere la sua primaria missione, la tutela del patrimonio culturale come sancito dall’articolo 9 della Costituzione. Non per caso ha giubilato un’intera classe dirigente certo zavorrata da qualche personaggio discutibile (come ogni amministrazione pubblica), ma in massima parte preparata e dedita alla causa, che per anni aveva tenuto in piedi il sistema in mezzo a grandi penurie, con stipendi da soglia di povertà: bocciandola ai concorsi da direttore, lasciandola invecchiare senza curarsi di avvicendarla e demoralizzandola ai limiti del vilipendio. Come se il ministero della difesa decidesse che l’esercito è inadeguato alla difesa nazionale e anziché investire risorse per migliorarlo congedasse gli ufficiali e sciogliesse tutti i reparti.
L’annunciato reclutamento di cinquecento tecnici e funzionari è senz’altro un’ottima notizia: ma costoro basteranno giusto a rimpiazzare i pensionati, mentre bisogna valutarne impiego e distribuzione. Che cosa dovranno fare? Quanto inciderà la loro preparazione? Conterà ancora essere un bravo storico dell’arte? O conterà di più essere un comunicatore-valorizzatore? I musei statali italiani sono intimamente legati al territorio, perché non derivano sempre da collezioni dinastiche indipendenti. A Firenze la Galleria dell’Accademia, di fresca autonomia, non esisterebbe se non l’avessero alimentata le opere di enti religiosi soppressi. Gli stessi Uffizi e il Bargello, che pure hanno origine dalle raccolte medicee, sono cresciuti grazie a quel che è giunto da altre collezioni, ma soprattutto dalla città. Una fisionomia che non è propriamente condivisa da nessun grande museo invocato quale termine di paragone, dal Louvre al Prado.
Proprio il confronto con queste realtà europee mette in luce il secondo aspetto su cui merita ragionare. Per fare un grande museo ci vuole una struttura adeguata ricca di professionalità differenziate. Per quanto sapiente, non esiste un direttore taumaturgo. Ma i nostri musei non sono intimamente riformati perché non hanno ancora una vera struttura autonoma. Un buon direttore non deve essere un manager, ma saperne abbastanza per scegliere il manager giusto e i collaboratori giusti. Invece non solo si sono fatti i direttori prima di fare gli uffici, ma nemmeno si è dichiarato quale modello di museo si vuole seguire. Una riforma definita “epocale” non può sgorgare dal nulla, ma va preceduta da un dibattito trasparente e condiviso, che comprenda un processo di revisione seria dell’esistente e un progetto di futuro. Ma qui non si vede revisione né progetto.
L’impressione è che da spina dorsale della coscienza civile il museo sia indotto a diventare esclusivamente un veicolo di promozione turistica buono a una valorizzazione monetaria di quel che contiene, alla faccia della conoscenza e della cittadinanza. Mentre si annunciavano le nomine dei megadirettori, all’ Expo di Milano si poteva ammirare un’incredibile mostra sull’arte italiana di ogni epoca, promossa da un ristoratore e curata da un pregiudicato, ove opere egregie e dozzinali erano accatastate come dal peggior rigattiere di provincia, in spregio alle più elementari norme di conservazione. Ma il primo nome che si leggeva sul colophon era quello del ministro per i beni culturali. Se l’Italia punta a una rinnovata leadership internazionale proprio sul fronte artistico, legittimare uno spettacolo così penoso è sintomo di contraddizioni, approssimazione, impreparazione che non si addicono né al rango né al patrimonio. Ci auguriamo che si tratti di eccezione e non di paradigma. Per questo il ministero farebbe bene ad avviare un confronto largo sul museo che vogliamo e soprattutto sul patrimonio che vogliamo. Perché l’arte non sta soltanto nei musei. E una politica che guardi solo i musei, e con lenti molto deformate, porta dritta alla cecità.
(Le righe che precedono sono state pubblicate sul numero di gennaio 2016 dell’”Indice dei libri del mese”. All’indirizzo https://www.academia.edu/20125268/Una_riforma_scintillante_e_punitiva_in_LIndice_dei_Libri_del_Mese_Gennaio_2016_XXXIII_1_p._6 è possibile visualizzare la pagina intera della rivista, comprendente anche un ampio intervento dell’archeologo Luca Cerchiai che evidenzia le criticità della riforma del Mibact nel settore di sua competenza. I brani sono stati scritti prima che fosse annunciata la fase ulteriore del processo, con l’accorpamento delle “soprintendenze archeologia” alle altre, ma credo che siano tuttora utili alla riflessione.)
- Fausto Zevi sulla riforma delle Soprintendenze
————————————————————————-
COSTITUENDO COMITATO DEL 22 MARZO -DOCUMENTO
Per autoconvocazione si sono riuniti, in Roma il giorno 22 marzo 2016, quasi duecento tra archeologi, storici dell’arte, architetti, funzionari delle soprintendenze, rappresentanti delle OO. SS., professionisti nel campo dei beni culturali, i quali tutti hanno preferito essere indicati come “operatori dei Beni Culturali”, a prescindere dall’eventuale appartenenza o ruolo in un’istituzione.
Già da questa comune denominazione i convenuti vogliono indicare come ritengano necessaria una stretta collaborazione non solo tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ma anche con quanti, pur non istituzionalizzati, operano nel campo dei beni culturali.
È, infatti, scopo comune il rafforzamento della tutela del patrimonio culturale grazie all’azione di operatori formati in maniera adeguata, attraverso successivi passaggi formativi.
Gli intervenuti auspicano che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca giungano concordemente alla definizione di una comune politica a favore dei beni culturali, di percorsi formativi, di strutture rivolte alla ricerca: il tutto a comporre un progetto culturale meditato e impostato su corrette basi di metodo, dal quale far discendere le attività organizzative e di gestione nel quotidiano. Fra le quali ultime sono da annoverare anche gli accordi rivolti a favorire la ricerca sul terreno, concordata e programmata.
Gli intervenuti hanno espresso non solo caute osservazioni sulla riforma in atto, ma anche aperte critiche. Queste, in specie, hanno riguardato la mancanza di un rendiconto certificato sull’attuazione del primo anno della riforma; l’istituzione dell’Istituto Centrale di Archeologia senza che si sia attuata l’ampia consultazione in precedenza promessa dal Ministro; la separazione tra tutela e valorizzazione; il declassamento della funzione conoscitiva e del riconoscimento delle specializzazioni tecniche, a partire da quelle del soprintendente.
In particolare, gli intervenuti richiedono una moratoria effettiva nell’applicazione della riforma: per la mancanza di una preventiva analisi dei fabbisogni di risorse, professionali e finanziarie, necessarie per il buon funzionamento degli istituti che si sono venuti a creare; per il mancato rispetto degli standard museali in molti degli istituti, considerati autonomi o raccolti nei poli museali.
L’auspicato progetto culturale tende anche a scongiurare il ripetersi delle fallimentari esperienze verificatesi in Sicilia, sulle quali ampie testimonianze sono state portate nel corso dei lavori.
Gli intervenuti chiedono la solidarietà di quanti hanno a cuore, in Italia ed in Europa e non solo, la conservazione, la conoscenza e la buona gestione del patrimonio culturale italiano.
I convenuti si riservano di adire tutte le vie possibili per diffondere e difendere tali proprie convinzioni in tutte le sedi, istituzionali e non.
Per il costituendo Comitato del 22 marzo:
Luca Cerchiai ([email protected])
————————————————————————-